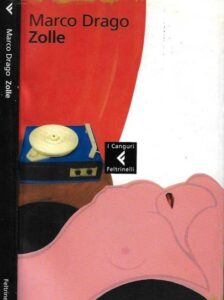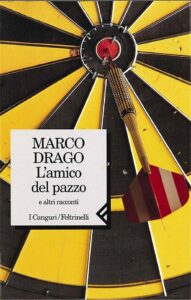(foto tratta dal profilo FB dell’autore)
“Cinque domande, uno stile” ospita Marco Drago. Scrittore, autore e conduttore di programmi radiofonici (ha collaborato negli anni con radio RAI e RADIO24), per Laurana editore cura la collana ebook “Reloaded”. Come scrittore ha esordito alla fine degli anni novanta con la raccolta di racconti “L’amico del pazzo” (1998, Feltrinelli) cui hanno fatto seguito, tra gli altri, “Domenica sera” (2001, Feltrinelli) e “Zolle” (2005, Feltrinelli), Da poco in libreria con l’ultimo romanzo “Innamorato” edito da Bollati Boringhieri.
Quando accade, quando un’idea, l’Idea, giunge e prende forma, si rappresenta nel suo immaginario, pronta ad essere modellata per diventare una storia, che sensazione si prova?
Ho un rapporto piuttosto pragmatico con la scrittura: per anni ho scritto le sceneggiature di programmi radiofonici che erano a tutti gli effetti delle fiction, dialoghi interpretati da attori e attrici e tante volte uno degli attori ero io. Erano puntate quotidiane, andavano in onda dal lunedì al venerdì, nove mesi all’anno. Potevo stare bene, male, averne voglia o no, essere ispirato o assolutamente a secco, dovevo scrivere circa 6500 battute a puntata. Moltiplicato cinque fa 37.500 battute alla settimana, spesso da scrivere in un paio di giorni al massimo. Capirete quindi che la sensazione che si prova quando arriva l’idea non potrà essere che di gratitudine. Non è facile scrivere 37.500 battute senza avere idee, è molto faticoso, si può fare – ve lo posso assicurare – ma quando uno straccio di idea si manifesta all’orizzonte tutto diventa più armonioso.
Se invece parliamo di romanzi o racconti, io non lavoro molto con le scalette per cui il tempo in cui scrivo e in cui mi vengono le idee coincidono, mi vengono le idee mentre scrivo. Non è semplicissimo perché non è possibile sostenere ritmi di scrittura molto elevati: si tratta di mezz’ora ogni tanto di scrittura sfibrante, un’ora al massimo, mai saputo scrivere quattro ore filate come fanno certe autrici o certi autori. Forse se mi costruissi delle belle scalette precise e tutte coerenti potrei anche mettere il pilota automatico e l’Idea di cui si parla nella domanda sarebbe quella che mi ha portato a stendere la scaletta. Il mio metodo invece è più dispendioso, nel senso che le idee mi devono venire di continuo, non ho alcuna contezza di un disegno a priori, quindi da un momento all’altro posso trovarmi con mezzo romanzo fatto, ma è un mezzo romanzo che non può più letteralmente andare avanti, e allora lo butto via. Mi è successo tantissime volte. È un mio difetto strutturale: non so progettare quasi niente in astratto, le cose io devo farle in fila da A a Z, non ho il dono dell’astrazione.
La consapevolezza che la parola appena scritta costituisca la conclusione di un racconto è evidente o necessaria?
La fine di un racconto o di un romanzo può arrivare in molti modi diversi, di solito ci lavoro meno che sull’attacco. A volte anzi il finale mi succede di buttarlo un po’ via, senza pensarci troppo. Credo ci voglia un talento specifico per i finali, così come per gli incipit, non sempre scrittori bravi a cominciare una storia in modo fulminante sono altrettanto bravi a chiuderla. In musica mi viene in mente il grande Frank Zappa, notoriamente scarsissimo nei finali, tanto che preferiva suonare tutti i brani senza pause tra l’uno e l’altro, due ore e mezza di concerto senza un secondo di silenzio. Poi però, il finale dei concerti era spesso volutamente stupido o confuso, oppure echeggiante un cliché, una parodia di finale. Evidentemente non gli riusciva nemmeno di inventarne uno. Mi sento sempre un po’ ridicolo a usare frasi a effetto, è una mia pecca, e si sa che se chiudi un capitolo o, meglio ancora, un libro intero con una frase a effetto, i lettori restano più soddisfatti, come un buon caffè alla fine del pasto rende sempre il cliente più contento. Ci sono storie che hanno un meccanismo tale per cui il finale non può che essere uno, altre che potrebbero continuare all’infinito e quindi diventa necessario troncare in qualche modo, e a quel punto un modo vale l’altro. In generale penso che il finale non sia così importante nell’economia di un romanzo, può esserlo di più nell’economia di un racconto o di una poesia. Sicuramente è fondamentale nell’economia di una barzelletta.
C’è stato, nel suo percorso di vita, netto e distinto, un momento di scelta in cui ha affermato a sè stesso “devo scrivere?”
Forse sì, verso i 16 anni, dopo aver letto le poesie di Georg Trakl. Mi aveva colpito la descrizione dei paesaggi della campagna austriaca nelle diverse stagioni dell’anno. Ricordo che cominciai a scrivere poesie subito, come mosso da un bisogno. Naturalmente quelle poesie erano imitazioni di Trakl, le ho ancora su un quaderno, ogni tanto le rileggo. Devo dire che a quell’età non ero un grande lettore, ero molto più attirato dalla musica rock e il mio sogno era quello di suonare in una rock band, avevo studiato il pianoforte da bambino e me la cavavo discretamente, però mi portavo appresso anche una certa indolenza e la tendenza a starmene da solo per intere settimane, mettere su una rock band era troppo complicato, non ci provai nemmeno. Dopo aver scoperto Trakl e, successivamente, Gottfried Benn, mi trovai quindi a scrivere poesie. Sia Trakl sia Benn si sposavano bene a una mia già consolidata fascinazione per certa musica cupa e cimiteriale che in quei primi anni ‘80 andava di moda nel Regno Unito. Là veniva definita “gothic”, in Italia invece “dark”. Ero un “dark”, mi vestivo di nero o grigio, leggevo i poeti tedeschi espressionisti e Baudelaire, ascoltavo The Cure, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees. Poi per lunghi anni provai anche a scrivere racconti, senza successo. Non leggevo la narrativa contemporanea, le mie fonti erano ancora tedesche ed erano tutte di epoche magari non lontanissime dalla mia, ma abbastanza lontane da non poter essere considerate prettamente contemporanee: Thomas Mann, Hermann Hesse e i più moderni Heinrich Böll e Günter Grass. Questo per parlare degli anni giovanili, i 16-17-18 anni. Scrivevo senza metterci un vero e proprio impegno, era un passatempo adolescenziale, più una posa che altro. Per fare sul serio ho dovuto aspettare una manciata di anni. Direi che i primi raccontini passabili li ho scritti intorno ai 23-24 anni: avevo cominciato a leggere Hemingway e Bukowski e poi scrittori più vicini alla mia generazione come P. V. Tondelli, Bret Easton Ellis, Jay McInerney, Raymond Carver. L’imitazione di quei modelli consentiva di raggiungere piuttosto agevolmente risultati accettabili perché, checché se ne dica, è infinitamente più facile creare un apocrifo di Carver che un aprocrifo di Thomas Mann. Nel frattempo avevo fondato una piccola rivista di poesie e racconti che si chiamava Il Maltese e i miei primissimi racconti li ho pubblicati proprio lì. A 25 anni lavoravo come impiegato commerciale a Canelli (Asti), la cittadina in cui sono nato. Nell’ufficio in cui lavoravo c’era un computer con un word processor e quando avevo dei momenti liberi scrivevo. Cominciai a lavorare a un lungo racconto strampalato a imitazione dello stile di Thomas Pynchon, il mio nuovo idolo letterario. Il racconto finì sulla rivista e la rivista finì nelle mani di Sandro Veronesi, che mi scrisse una lettera facendomi mille complimenti per il racconto. Quella lettera mi diede così tanta fiducia (diceva qualcosa come «secondo me, lei, Drago, è un vero scrittore») che da quel momento presi il mio hobby molto più seriamente di quanto avessi fatto fino ad allora. E così sono arrivato piano piano a scrivere racconti sempre migliori fino a pubblicare la mia prima raccolta per Feltrinelli nel 1998, a 31 anni.
Lo stile è un passaggio che ciascun autore percorre, può in qualche modo divenire un vincolo?
Ogni scrittore ha (o dovrebbe avere) uno stile di scrittura unico, esattamente come ogni essere umano ha un timbro di voce unico. Lo scrittore, però, è un essere umano che può camuffare il proprio timbro di voce, è come un imitatore. Se il successo (commerciale quando va bene, di critica quando va male) arriva con un libro in cui uno scrittore tratta un materiale che lo costringe a usare un timbro di voce artefatto, non autenticamente suo, allora quel timbro di voce diventa un vincolo perché quello scrittore tenderà di suo o sarà persuaso dagli editori a replicarlo. Sottolineo, della frase sopra, le parole «un materiale che lo costringe a usare un timbro di voce» perché stile e contenuto non sono separabili. Il contenuto influenza la forma, inutile provare a ribellarsi. Certo, in tempi di letteratura postuma come quella di oggi, si saranno anche visti esperimenti in cui un autore tratta un certo argomento usando consapevolmente uno stile inadatto o in contrasto con quello che racconta, però generalmente lo stile si adatta al contenuto, quindi ragionare in astratto sullo stile mi pare un’operazione ad alto rischio di aria fritta.
In quale misura crede che la letteratura oggi riesca ad incidere nella società e con quale forza lo scrivere costituisca un gesto politico?
Da quando pubblico libri (25 anni quest’anno) la letteratura non ha mai avuto alcun peso sulla società. Parlo per l’Italia. Sarà perché ci si legge tra colleghi e poco più, sarà perché i politici non hanno idea di chi siano gli scrittori del loro tempo, resta il fatto che le migliaia di libri che escono ogni anno sembrano scritti da cani che abbaiano in una stanza vuota. Ma non da oggi. Forse (forse) Pasolini, Moravia, Calvino, avevano un uditorio leggermente meno deprimente. Ma non posso saperlo perché non ero ancora nato o ero un bambino, devo fidarmi delle cronache e della mia percezione. La letteratura ha perso la sua presa sulla società molto tempo fa, credo. Nel ‘900 prima i registi cinematografici, poi i musicisti rock e infine i tecnici hanno avuto un peso molto maggiore degli scrittori. Scrivere un romanzo oggi è deliziosamente inutile e anacronistico. Purtroppo per loro ci sono persone che sanno solo fare quello e continuano a farlo senza ricavarne altro che quel po’ di (puerile) soddisfazione personale che viene spesso travestita da qualcosa di più nobile. La percentuale di autori che riesce a ricavarne anche soddisfazione materiale è infima. Personalmente rifuggo l’idea che la scrittura sia un atto politico. Io leggo e scrivo solo per intrattenermi e intrattenere. Sono un figlio degli anni ‘80 e da lì non sono mai riuscito a uscire. Vado al cinema, leggo libri e ascolto musica per ottenerne godimento estetico. Per tutto il resto c’è la vita. È dal rapporto con le altre persone, dai fatti reali che mi succedono ogni giorno, che traggo le informazioni che mi consentono di sopravvivere come meglio posso. Quello che chiamiamo “politica” è impermeabile a tutto, l’unica cosa che fa muovere il mondo sono gli interessi economici. Ad altissimi livelli (Hollywood?) il giro di denaro generato dall’industria culturale, forse, si riverbera anche sulla politica, ma a quegli altissimi livelli è difficile distinguere le cose, per esempio il cinema dalla finanza. Quelli come me è come se vivessero su un altro pianeta.