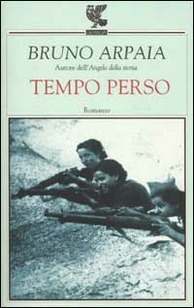“Cinque domande, uno stile” ospita oggi Bruno Arpaia. Scrittore, traduttore e giornalista. Cesellatore della parola. Esordisce con il romanzo “I forestieri” (1990, – vincitore del premio Bagutta opera prima nel 1991) cui seguono tra gli altri, “Tempo perso” (1997, Marco Tropea Editore – riedito da Guanda nel 2003), “L’angelo della storia” (2001, Guanda – vincitore del premio Campiello 2001), “La cultura si mangia!” (2013, Guanda – con Pietro Greco), “L’avventura di scrivere romanzi” (2013, Guanda – con Javier Cercas) fino all’ultimo “Il fantasma dei fatti” (2020, Guanda).
Ha dato voce a molti degli scrittori sudamericani di grande fascino, tra i quali ricordiamo Fernando Aramburu (“Anni lenti”, “Patria” editi da Guanda), Manuel Vilas (nello splendido “In tutto c’è stata bellezza”, 2019, Guanda), Javier Cercas (“L’impostore”, “Terra alta”, “Indipendenza”, Guanda), Carlos Ruiz Zafón (“Il gioco dell’angelo”, “Il prigioniero del sole” editi da Mondadori) Inoltre, ha curato le edizioni dei Meridiani Mondadori dedicate a Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa.
Quando accade, quando un’idea, l’Idea, giunge e prende forma, si rappresenta nel suo immaginario, pronta ad essere modellata per diventare una storia, che sensazione si prova?
L’idea di solito non arriva di colpo, come mandata dal cielo. Spesso, seguendo un’immagine, un personaggio, una sequenza di parole che cominciano a ossessionarti, si parte per un lungo e difficile viaggio fatto di disciplina, di letture, di riflessioni, di documentazione, di approssimazioni che a volte conducono a una meta e a volte si rivelano una falsa pista. Raramente mi è accaduto di essere folgorato dall’«Idea», ma è avvenuto sempre dopo mesi e mesi di lavoro, di concentrazione, di disciplina; come quando capii (stavo lavorando a “L’angelo della storia”) come mettere insieme due personaggi tanto diversi come Walter Benjamin e l’immaginario rivoluzionario spagnolo Laureano Mahojo. Fu una notte, tanti anni fa, durante un viaggio in treno da Milano a Napoli. Niente ispirazione: non ci credo. Scrivere è un mestiere, un faticoso artigianato, checché ne pensino i vecchi e nuovi romantici. Però è vero che uno dei pochi privilegi di uno scrittore è quello di vivere momenti bellissimi, purtroppo molto, molto rari: momenti in cui è come se di colpo ti si squarciasse un velo sulle storie che vorresti raccontare, sui personaggi che ti ronzano in testa in forma vaga, confusa. All’improvviso diventano chiari, netti, ti sembra di conoscerli da anni e anni e di averli accanto in carne e ossa. A me accadde nella cuccetta di quel treno: in uno stato di inquietissimo dormiveglia, vidi nitidamente quei due parlare fitto fitto sui Pirenei, la notte in cui Benjamin rimase solo durante la sua avventurosa fuga prima di suicidarsi a Port Bou. Erano lì, nel buio, Laureano e il vecchio Benj, e si parlavano. Dopo, si è trattato “solo” di scriverla, quella storia.
La consapevolezza che la parola appena scritta costituisca la conclusione di un racconto è evidente o necessaria?
Regole, non ne esistono. All’inizio scrivevo con poco meno di una vaga bussola, lasciandomi trasportare dalla scrittura. E scoprivo il finale quando ci arrivavo, quando «sapevo» che lì la mia storia si esauriva. Poi, a mano a mano, con l’esperienza, o forse con l’età, prima di iniziare a scrivere, o nelle prime fasi di stesura, ho cominciato a intravedere più chiaramente dove voglio andare a parare. Ma lo intravedo, appunto. Poi bisogna trovare la forma in cui dirlo, scoprire e cesellare quell’ultima, decisiva frase. Come ho detto, si tratta sempre di artigianato; nobile quanto si vuole, ma pur sempre artigianato.
C’è stato, nel suo percorso di vita, netto e distinto, un momento di scelta in cui ha affermato a se stesso “devo scrivere?”
Lo so, è un classico, ma scrivere mi ha affascinato fin da bambino. Tuttavia, la consapevolezza e la grande determinazione necessarie a decidere di voler essere uno scrittore mi sono venute soltanto dopo aver letto “Cent’anni di solitudine”. Fu un’illuminazione, un cataclisma che fece piegare la mia vita come un martello che batteva sopra un ferro caldo. Erano tempi di rigide militanze politiche, i dirigenti ci consigliavano addirittura di leggere saggi e di non perdere tempo con i romanzi… E invece, mi scoprii a pensare leggendo García Márquez, il mondo poteva anche non essere soltanto in bianco e nero: si poteva restare ancora dalla parte giusta e vivere a colori. Bastava solo sapere usare bene le parole. Fu lì che mi decisi: da grande non avrei fatto né il pompiere né l’astronauta, ma lo scrittore. «Ma che, sei pazzo?» mi disse un caro amico. Era più o meno l’epoca in cui uccisero Aldo Moro. Tra Stato e terrorismo, avevano calato un bel coperchio sulla bara di chi aveva immaginato di cambiare almeno un poco il mondo. Per continuare a immaginare e a sperare, per continuare a dire “noi”, non mi restava altro che lo scrivere. Ricordo ancora la faccia attonita di quell’amico, la sua espressione allo stesso tempo sprezzante e preoccupata: «E cosa mangerai? Parole?». Il problema di mangiare non l’ho ancora risolto benissimo, ma oggi quello che mangio me lo guadagno proprio con le parole. Non potevo sperare di più.
Lo stile è un passaggio che ciascun autore percorre, può in qualche modo divenire un vincolo?
Lo stile si sceglie, anche se seguendo vicoli e sentieri non sempre evidenti, non del tutto consapevoli. Ha perfino a che fare con il metabolismo del proprio corpo, con il respiro, con il ritmo. E cambia, nel corso della vita. Negli anni, il mio si è asciugato, direi quasi essenzializzato. Ma è solo il “mio” percorso. Poi, è chiaro, anche quella scelta è un vincolo. Ma senza vincoli, senza paletti, non si fa arte, non si fa scienza, non si fa quasi nulla. Qualunque creazione, qualunque invenzione, non nasce dalla semplice fantasia, inconsapevole e sfrenata, ma dalle costrizioni. La lunghezza dei capitoli di Dickens era determinata dalla necessità di stamparli a puntate sul giornale. Michelangelo, come ricorda Sklovskij, amava scegliere blocchi di marmo danneggiati, perché in questo modo conferiva pose inaspettate alle sue sculture…
In quale misura crede che la letteratura oggi riesca ad incidere nella società e con quale forza lo scrivere costituisca un gesto politico?
Diciamocelo: temo che oggi la letteratura, visti i livelli di lettura e l’analfabetismo funzionale in crescita dovunque, incida davvero poco sulle nostre società. Non così le narrazioni in genere (film, serie televisive, videogiochi…), che hanno ancora un forte impatto. E tuttavia, la funzione politica, etica, civile della letteratura non viene meno. La letteratura, la buona letteratura, parla sempre a partire da un «noi», cambia l’immaginario collettivo, ci fa immaginare mondi possibili, aumenta la nostra capacità di empatia, ci fa vivere altre vite e immergere in esperienze che diversamente non potremmo mai fare. Di più: in questi tempi così inclini a semplificare il mondo, alla nostalgia del semplice, alle fake news e alle teorie complottistiche, contribuisce a non semplificare e svilire la realtà, a restituircela in tutta la sua complessità, ponendoci domande sempre più complesse a cui non fornisce una risposta univoca e semplicistica. Non mi viene in mente nulla di più politicamente rivoluzionario.