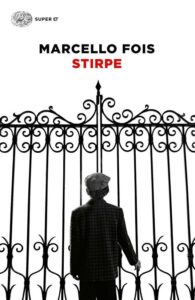– Marcello Fois, 2011 – Einaudi – pp. 243 – € 12,00.
Era tutto un dirsi Ti ricordi? E i libri nei cesti come pane, che c’era da nutrire un corpo dentro al corpo e c’era l’impellenza di prepararsi all’esercizio quotidiano del tempo.
“Stirpe” di Fois apre la trilogia familiare incentrata sui Chironi (completata dai successivi volumi “Nel tempo di mezzo” e “Luce perfetta” tutti editi da Einaudi), attraversando l’Italia dalla prospettiva periferica – se periferica può definirsi una prospettiva di tale portata – della Sardegna, la cui evoluzione avanza di pari passo alle vicende dei personaggi. Scrivere di un romanzo particolarmente affascinante e complesso in cui l’autore riesce ad intrecciare senza imbarazzi stili differenti, linguaggi sublimi e quotidiani, può far correre il rischio di impantanarsi nella banalità dei luoghi comuni sulle saghe familiari così tanto di moda e attuali. Ma Fois gioca un altro campionato per dirla con linguaggio da bar dello sport, un altro livello. Fois rimane, resta nella memoria delle sue pagine, nei pensieri di chi le ha lette, scorgendovi l’incedere del tempo, così comune, così lento, così immobile da rimetterci agli occhi le immagini ritratte dall’arte letteraria, non così comune, non così lenta, non così immobile, come il tempo che traccia.
Annotazioni di lettura:
Volevo vivere nel vuoto, nella luminosità di un presente costante.
Gli amori durano esattamente un momento perfetto, il resto è solo rievocazione, ma quel momento può essere sufficiente a dare un senso a più di una vita.
Sono le briciole del banchetto quelle che si devono mangiare in questa fetta di mondo, ma, a ben guardare, e ben assaporare, da queste briciole si possono capire tante cose.
C’erano cose che avrebbe potuto dire, se solo avesse saputo dirle…
come nelle case dei signori che hanno bisogno anche di cose inutili. Anzi, essere signori significa avere cose che non servono…
ripercorrere un percorso a ritroso non incide sul futuro se non in termini di coscienza di sé.
la Storia cammina avanti e indietro e forse va a spirale, o gira in tondo, o dirazza, ma mai, mai procede lineare, dritta e sibilante come una freccia…
lo Stato punisce amaramente chi non capisce di farne parte, perché l’ignoranza non è ammessa, ma auspicabile;
quanto vicino bisogna guardarsi per andare lontano.
Perché non è che si diventa deboli solo per mancanza di energie, ma anche per eccesso di sensibilità.
quello che aveva le parole per dire le cose, e sempre avere le parole significa farle succedere le cose.
Io subirò la mia Storia, piccola o grande che sia. Finirò per credere di essere solo in transito su questa terra e invece lascerò un segno. Penserò d’essere venuto al mondo in un posto crudele e malato d’oblio, ma sarà solo la dimostrazione della mia ignoranza.
Qualche padre mi ricorderà quello che non voglio e non posso ricordare. La sostanza della Memoria è un cane che guida un gregge, un’ ombra disegnata sui muri.
Dalla precisione con cui riuscirò a determinare il corso ostinato delle ricorrenze dipenderà gran parte del mio andare e venire.
Penserò d’essere nato in un posto ridotto a galera, a terra di punizione, ma un padre artigiano, dal profondo di racconti mai dimenticati, mi dirà di mari solcati, di civiltà prospere e di terre feraci come l’Eden. Oltre i monti.
Starò bene, oh certo. Eppure da sempre l’altrove mi sussurrerà parole più rotonde, malie di mondi irraggiungibili.
Io sempre abiterò questa precisa, maledetta, condizione d’inferiore desiderio.
avere la certezza che per sopravvivere bisogna rassegnarsi a morire.
alla fine vince solo chi muore di meno.
la guarigione è quasi una punizione, perché fuori dal sepolcro devi fare i conti con tutto quello che hai capito quand’eri dentro.
per poter decidere di non fare una cosa devi dimostrare di saperla fare.
Ti ricordi la speranza trasparente dei vetri? Mi ricordo come cristallo il mio tempo, questo sì. E il tuo come un pugnale di luce, dentro me, oltre me. Il tuo come una pennellata scura a formare il profondo. Non potevo, davvero non potevo! Sono andato via, ma ho abbandonato soprattutto me stesso. Mi sono messo in posa, ho lasciato che mi dipingessi come una natura morta di tempo vivo. Come un oggetto che non sa resistere all’abbraccio del colore, che lottando contro il buio si espone a una corposità tattile. Ti ricordi? Era uno sfregio di riflessi, era come sapere di avere un peso, una consistenza. Era una promessa. Era stabilire punti fermi, da dove corre lo sguardo all’oggetto di quello sguardo. Era ferocia del pittore. Era memoria consistente. Oh… Ridotte a una voce sola le cose si amalgamano e fluiscono nel corso del tempo a cui non abbiamo concesso tempo. E il silenzio fragoroso della vita che scorre dentro alla convessità di una brocca, è l’occhio vigile del rapace notturno, è la veglia con lo sguardo trafitto dalla pagina stampata. Ti ricordi? Tutto quello che ti ho dato è nero, tutto quello che mi hai dato è luce.
C’è un cielo di nubi viola che scolano sangue denso sul campo. E c’è un amalgama terribile di Nulla e Tutto… Come la nostra coscienza che vaga nel troppo dichiarato sino a produrre solo silenzio. Quante cose vorremmo sentirci dire e nessuno ce le dice.
A volte poteri contrapposti fingono di essere nemici, fanno teatro, ma alla fine si accordano sempre.
Quanto serva il dolore lo sa solo chi vigliaccamente, con prepotenza, ha cercato di sfuggirlo.
Poi. Che sempre il poi ci attende mascherato nell’ostinazione precaria dell’ora. Nella brillantezza dell’oro. Nella densità liquorosa della preinfanzia. Quando ancora non siamo presente, ma condizionale. Adatti a ogni tempo, subiamo il ciclo completo di un’esistenza in prova, subiamo ogni singolo istante di secoli. Che poi siamo già qualcosa fuori dall’arbitrio delle possibilità. E ancora vortica il ciclo segreto delle precarietà.
Proprio quando tutto sembra immobile, stabile di una stabilità complessa, proprio in quel momento, quando l’equilibrio pare immortale, quando pare che la stasi abbia preso il sopravvento, allora s’insinua il tarlo dell’incertezza, l’ansia sottile della durata, l’angoscia del tempo. Nella precarietà dell’equilibrio frontale c’è una storia che non è stata raccontata.
Sì. Nella specificità di un senso compiuto permane l’irrealtà. Una porzione di verità che non ha parole per esprimersi. Alla stregua di una grande natura morta che è tempo fissato, incollato alla tela, sottratto al divenire. Soltanto nell’attesa, soltanto nell’attesa ci si può conciliare con quell’iconica fissità. Aspettandosi che il calice cada, che quel cristallo, finalmente, si frantumi…
E la fine non è una fine.