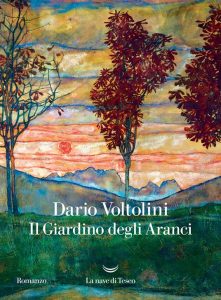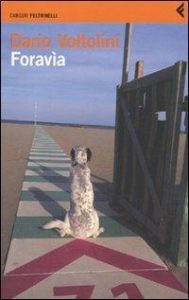“Cinque domande, uno stile” ospita Dario Voltolini. Poliedrico scrittore, si è cimentato nel racconto, nel romanzo, ha prodotto volumi illustrati, è autore di testi di canzoni. Fra i suoi libri segnaliamo: “Una intuizione metropolitana” (1990, Bollati Boringhieri), “Rincorse” (1994, Einaudi), “Forme d’onda” (1996, Feltrinelli – poi 2014, Laurana Editore), “Le scimmie sono inavvertitamente uscite dalla gabbia” (2006, Fandango), “Foravía” (Feltrinelli 2010), “Pacific Palisades” (2017, Einaudi), fino all’ultimo delizioso e melanconico romanzo “Il giardino degli aranci” (2022, La Nave di Teseo).
Quando accade, quando un’idea, l’Idea, giunge e prende forma, si rappresenta nel suo immaginario, pronta ad essere modellata per diventare una storia, che sensazione si prova?
Di solito ho cinque-sei idee abbozzate in testa, che cercano tutte una forma più stabile. Alcune si inabissano e poi ritornano, altre emergono fino a quasi convincermi, poi si sgonfiano. Quando emergono è perché per loro ho intravisto un finale. Ma spesso questo finale non regge alla prova della tenuta, ed ecco che per questo si sgonfiano, sostituite da quelle che si erano inabissate e che tornano su per farsi vedere. È un processo costante, anzi direi che è una condizione. Quando poi una di queste davvero prende forma, e va sulla pagina e il finale la sostiene e mi convince, allora per poco tempo le altre tacciono e questa continua a battermi in testa: la rileggo, la ripenso, vado avanti così. Poi lei se ne va, stampata o comunque pubblica. Dopo qualche tempo ricomincia la solfa, e magari c’è una new entry che comincia a fare capolino. La sensazione che si prova in tutto questo è quella buona: sto lavorando (anche se non si vede).
La consapevolezza che la parola appena scritta costituisca la conclusione di un racconto è evidente o necessaria?
Più che la parola per me a mettere fine a un lavoro è sempre una frase. E allora è sia evidente sia necessaria.
C’è stato, nel suo percorso di vita, netto e distinto, un momento di scelta in cui ha affermato a sé stesso “devo scrivere?”
No, mai. Soprattutto mai “devo”. È però capitato, dopo il primo libro (“Una intuizione metropolitana”, 1990) che per un po’ non avessi più pensato a scrivere. Poi mi sono reso conto che ero in una situazione particolare che non si sarebbe probabilmente più ripetuta, cioè lavoravo in un laboratorio di ricerca all’Olivetti, eravamo un gruppo multidisciplinare, il laboratorio lo stavano chiudendo. Cioè mi trovavo in una situazione in cui non c’era nessuno scrittore a testimoniare di quei mesi, solo io. Lì sì mi sono detto: “Questo devo scriverlo io”. Così ho scritto il mio secondo libro, “Rincorse” (1994).
Lo stile è un passaggio che ciascun autore percorre, può in qualche modo divenire un vincolo?
Quella dello stile è una questione molto complessa. Di solito si pensa che uno il proprio stile se lo debba guadagnare, costruire, partendo dal nulla. Invece lo stile (in un’accezione primitiva) è come le impronte digitali: uno ce l’ha da subito. Solo che questo stile può essere disastroso. Lì sopra si lavora, consciamente o inconsciamente, aiutati da altri o da soli, e si arriva a uno stile (in una seconda accezione) che è quello che di solito si intende parlando di stile. Ma è una mediazione tra un dato quasi caratteriale e ciò che siamo riusciti a farne. In questo lavorio tra l’uno e l’altro c’è uno spazio di libertà, difficilmente un vincolo.
In quale misura crede che la letteratura oggi riesca ad incidere nella società e con quale forza lo scrivere costituisca un gesto politico?
Cento euro in più in busta paga incidono molto più direttamente sulla realtà di quanto possa fare la letteratura. In un altro senso, poi, va detto che è la realtà che deve incidere sulla letteratura, quasi più che il contrario. Tuttavia questa “ realtà” che deve incidere sulla letteratura non è scontato che sia quella che di default abbiamo sotto gli occhi. Ma qui il discorso diventa molto complicato. In un terzo senso, che ha più direttamente a che fare con il politico, la letteratura (e non solo) sta subendo un attacco politico diretto, su ciò che si può o non si può dire, su ciò che si presume la letteratura debba dire, su come debba dirlo. Allora il gesto politico della letteratura oggi come oggi, se c’è, è soprattutto di resistenza, di presidio e mantenimento di spazi di libertà mentale e artistica. Nel caso migliore, è di allargamento di questi spazi. È una questione di statuto del gesto letterario, più che di contenuto dello stesso.